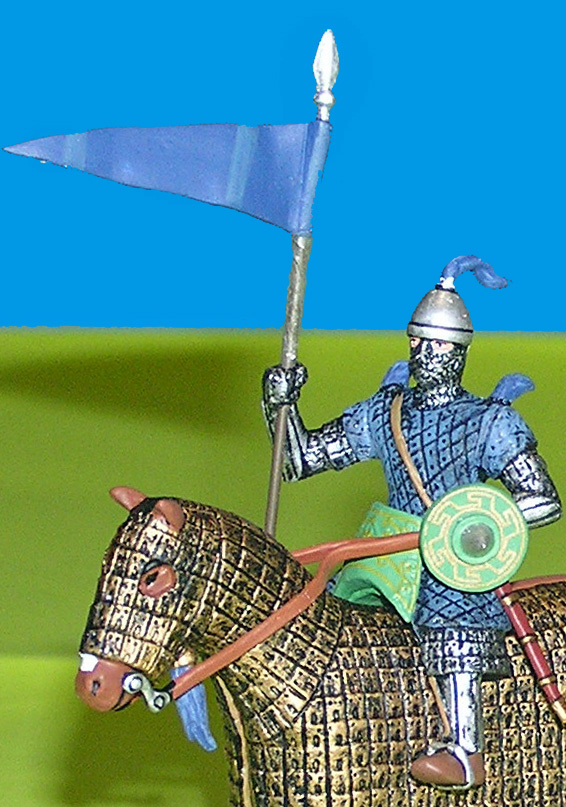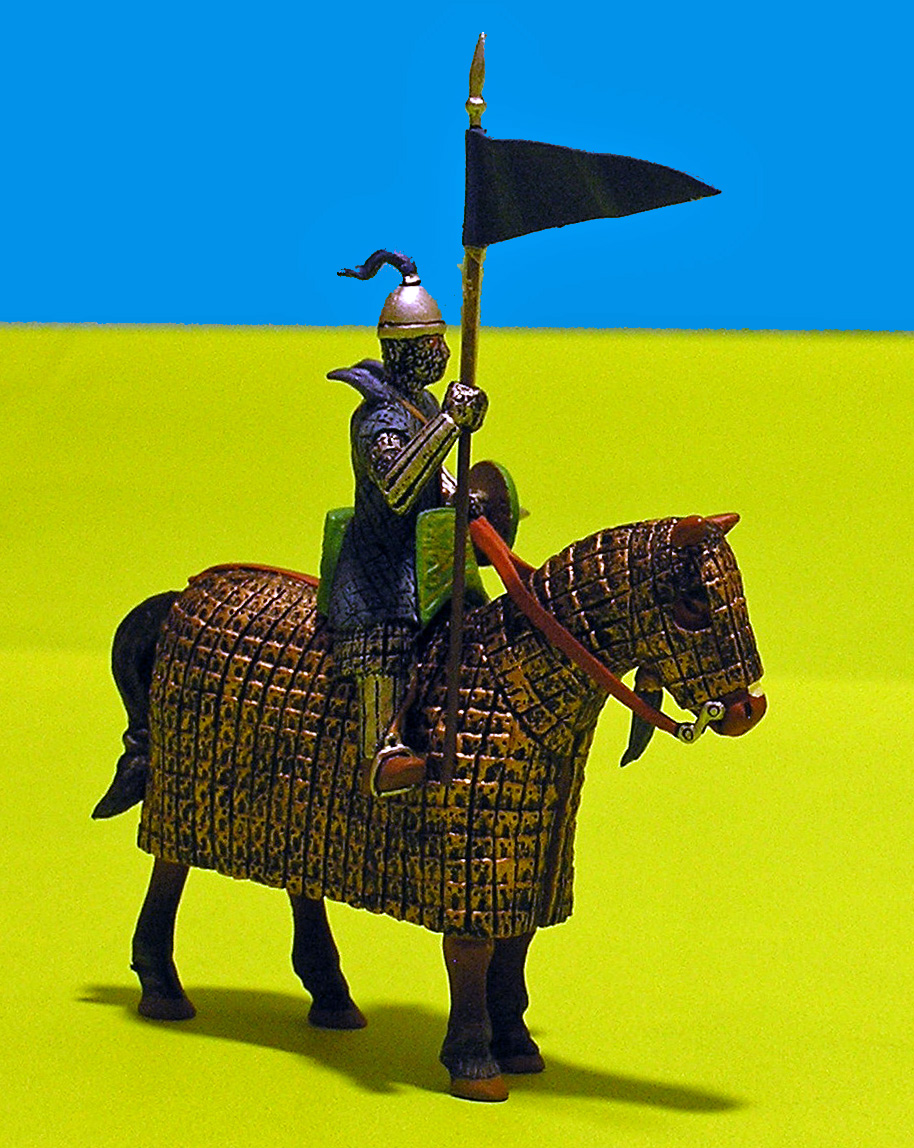Fin dalla metà del IX
secolo, la politica dell'Impero bizantino mirò soprattutto alla difesa e al
consolidamento delle frontiere. Lo storico Leone Diacono, a proposito del regno
del basiléus Giovanni I Zimisce
(969-976), contraddistinto da una serie di vittoriose campagne militari contro
Russi, Bulgari e Saraceni, scrisse che questi “apprezzava molto di più la pace della guerra, perché sapeva che, se la
prima donava ai popoli la salvezza, la seconda, al contrario, era causa della
loro distruzione”. La guerra, dunque, veniva considerata come ultima ratto,
da applicarsi solo in seguito al definitivo fallimento della macchina della
diplomazia che, tra l'altro, era estremamente dispendiosa poiché faceva ricorso
a costosi doni e a regolari pagamenti a principi o capi stranieri. Un tipo di
politica che non sminuiva il prestigio dell'Impero, ma che, al contrario, era
considerato un saggio principio di governo e una conquista diplomatica, dato
che il denaro serviva soprattutto per assicurarsi fedeli alleati in tempo di
guerra o a mettere i 'barbari' gli uni contro gli altri, come avvenne, per
esempio, nel caso dei Cumani, sfruttati dai Bizantini per respingere i
Peceneghi (091). Pretendenti al trono o rifugiati politici furono sempre bene
accetti presso la corte degli imperatori di Costantinopoli, perché considerati
dal governo come pedine da 'usare' in politica estera per ostacolare un
possibile antagonista ed esercitare pressioni sulle potenze straniere. Nel
gioco diplomatico bizantino, inoltre, ebbero un ruolo determinante anche i
matrimoni politici e l'azione dei missionari cristiani per la conversione delle
confinanti popolazioni pagane.
Torna ai Cavalieri Medievali